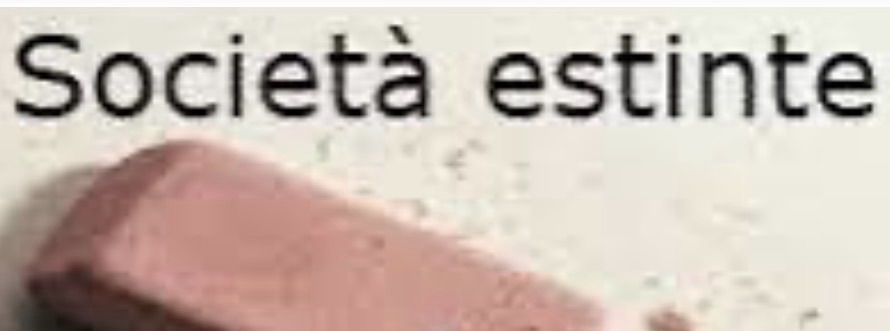
Liquidazione giudiziale e società estinte: il regime normativo aggiornato e le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno
Il quadro normativo concorsuale vigente
La disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza è oggi regolata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), recentemente aggiornato dai decreti correttivi D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, e D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. Decreto correttivo ter). Quest’ultimo decreto, entrato in vigore il 28 settembre 2024, ha perfezionato l’armonizzazione normativa con le disposizioni della Direttiva UE 2019/1023, rafforzando le procedure di ristrutturazione preventiva, esdebitazione e liquidazione.
L’articolo 390 del Codice sancisce la ultrattività della previgente Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, mentre la giurisprudenza di legittimità ha precisato che le disposizioni codicistiche hanno valenza interpretativa solo quando sussiste continuità tra il vecchio e il nuovo regime (Cass., Sez. Un., 25-3-2021, n. 8504).
Principi generali della riforma concorsuale
Tra i principi cardine della Legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, recepita nel Codice della crisi, si evidenziano:
- Unitarietà del procedimento concorsuale: tutte le iniziative giudiziali relative a un medesimo debitore confluiscono in un unico procedimento, presieduto da un giudice delegato (art. 7 c.c.i.; Cass., Sez. I, 8-5-2024, n. 12523).
- Continuità aziendale: priorità alle soluzioni che assicurano la prosecuzione dell’attività economica e il miglior soddisfacimento dei creditori, riservando la liquidazione giudiziale come extrema ratio (art. 1, co. 1, lett. g, legge n. 155/2017).
- Allargamento della concorsualità: il Codice favorisce una gestione integrata dei conflitti tra debitore e creditori, incentivando il risanamento dell’impresa anche mediante strumenti di natura privatistica con effetti pubblicistici (Cass., Sez. Un., 31-12-2021, n. 42093).
Crisi e insolvenza: definizioni e implicazioni
Il Codice distingue chiaramente tra crisi e insolvenza (art. 2 c.c.i.):
- La crisi indica uno stato probabile di insolvenza, evidenziato dall’inadeguatezza dei flussi di cassa nei successivi dodici mesi.
- L’insolvenza rappresenta uno stato concreto e stabile di incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni con mezzi ordinari, rilevabile anche attraverso un singolo inadempimento significativo (Cass., Sez. I, 11-3-2019, n. 6978; Cass., Sez. I, 18-1-2019, n. 1465).
L’insolvenza è valutata dinamicamente, considerando l’intera operatività dell’impresa, e non esclusivamente il rapporto tra attivo e passivo (Cass., n. 29913/2018; Cass., Sez. VI, 20-1-2020, n. 1069).
Presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale
L’impresa può essere sottoposta a liquidazione giudiziale solo se soddisfa specifici requisiti dimensionali e si trovi in stato di insolvenza (art. 121 c.c.i.):
- Attivo patrimoniale annuo ≤ 300.000 € nei tre esercizi precedenti;
- Ricavi complessivi annui ≤ 200.000 € nei tre esercizi precedenti;
- Ammontare dei debiti ≤ 500.000 € (anche non scaduti).
La giurisprudenza ha chiarito che nel computo dell’indebitamento rilevano anche i debiti contestati, iscritti nei bilanci o accantonati a fondi rischi ed oneri (Cass., Sez. I, 12-1-2017, n. 601).
L’onere probatorio della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale grava sul debitore, che può avvalersi di bilanci, scritture contabili o altri documenti, anche formati da terzi (Cass., Sez. I, 9-11-2020, n. 25025; Cass., Sez. VI, 10-5-2022, n. 14819).
La liquidabilità della società estinta
Il Codice della crisi consente l’apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente o entro l’anno successivo (art. 33 c.c.i.).
- La società estinta mantiene la capacità processuale ai fini della procedura concorsuale, in virtù di una fictio iuris (Cass., Sez. I, 6-8-2021, n. 22449).
- L’orientamento giurisprudenziale consolidato stabilisce che i crediti della società sopravvivono alla cancellazione, salvo una manifestazione inequivoca di volontà di remissione da parte del creditore (Cass., Sez. Un., 16-7-2025, n. 19750).
La sorte dei crediti e dei debiti residui
- Società di capitali: i crediti non soddisfatti possono essere fatti valere nei confronti dei soci fino all’importo riscosso in sede di liquidazione e nei confronti dei liquidatori in caso di loro colpa (art. 2495 c.c.).
- Società di persone: responsabilità dei soci variabile secondo il tipo societario, con possibilità di estensione ai soci accomandanti limitatamente alla quota di liquidazione (artt. 2312 e 2324 c.c.).
In caso di cancellazione volontaria, la giurisprudenza ha precisato che non si presume automaticamente la rinuncia ai crediti non iscritti in bilancio; l’onere di dimostrare la remissione del credito grava sul soggetto che intende opporsi alla pretesa (Cass., Sez. Un., 16-7-2025, n. 19750).
L’articolo 2495 del codice civile disciplina la sorte dei crediti sociali non soddisfatti al termine della liquidazione di una società di capitali. In sintesi:
- Responsabilità dei soci: i creditori insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme che questi hanno ricevuto durante la liquidazione finale. Questo riflette il principio dell’autonomia patrimoniale perfetta, tipica delle società di capitali, limitando la responsabilità dei soci all’ammontare effettivamente percepito.
- Responsabilità dei liquidatori: i liquidatori rispondono solo se il mancato pagamento dei crediti è derivato da loro colpa (negligenza, imperizia o violazione dei doveri di legge).
In pratica, l’art. 2495 c.c. tutela sia i creditori, garantendo una via di soddisfazione residua, sia i soci, limitando la loro esposizione patrimoniale, e attribuisce ai liquidatori un obbligo di diligenza nella gestione della procedura di liquidazione.
confronto tra società di capitali e società di persone riguardo ai crediti sociali non soddisfatti in sede di liquidazione:
1. Società di capitali (S.p.A., S.r.l.)
- Responsabilità dei soci: limitata all’importo effettivamente riscosso durante la liquidazione.
- Responsabilità dei liquidatori: i liquidatori rispondono solo in caso di colpa (art. 2495 c.c.).
- Autonomia patrimoniale: perfetta; il patrimonio della società è distinto da quello dei soci, quindi i creditori possono soddisfarsi solo sul patrimonio sociale e, residualmente, fino alle somme riscosse dai soci.
2. Società di persone (S.n.c., S.a.s.)
- Società in nome collettivo (S.n.c.):
- I creditori insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci in proporzione alla responsabilità illimitata prevista dalla legge.
- Anche i liquidatori rispondono se il mancato pagamento dipende da loro colpa (art. 2312 c.c.).
- Società in accomandita semplice (S.a.s.):
- I soci accomandatari hanno responsabilità illimitata per i debiti sociali.
- I soci accomandanti rispondono solo fino alla quota di liquidazione.
- Anche qui, i liquidatori rispondono in caso di colpa.
3. Differenze principali
| Aspetto | Società di capitali | Società di persone |
|---|---|---|
| Responsabilità dei soci | Limitata alle somme riscosse | Illimitata (S.n.c.) o limitata alla quota di liquidazione (S.a.s.) |
| Patrimonio | Autonomia perfetta | Patrimonio sociale e personale dei soci collegati |
| Ruolo liquidatori | Rispondono solo per colpa | Stessa regola: rispondono solo per colpa |
| Tutela creditori | Limitata al patrimonio sociale e somme riscosse dai soci | Può coinvolgere direttamente il patrimonio personale dei soci (S.n.c.) |
In sintesi, la differenza chiave risiede nella responsabilità patrimoniale dei soci: nelle società di capitali è limitata, nelle società di persone può essere illimitata, con conseguente maggiore esposizione personale dei soci verso i creditori.
Considerazioni conclusive
Il regime concorsuale introdotto dal Codice della crisi e aggiornato dai decreti correttivi ha rafforzato la disciplina della liquidazione giudiziale, distinguendo chiaramente tra crisi e insolvenza, prevedendo requisiti dimensionali stringenti e tutelando sia i creditori sia la certezza dei rapporti giuridici.
Le competenze dello Studio Legale Bonanni Saraceno
Lo Studio Legale Bonanni Saraceno vanta una consolidata esperienza in materia di diritto concorsuale e crisi d’impresa, con particolare riguardo a:
- Apertura e gestione di procedure di liquidazione giudiziale;
- Assistenza nell’accertamento dello stato di insolvenza e nella valutazione dei requisiti di non assoggettabilità;
- Supporto nelle società estinte e nella gestione dei rapporti con creditori e soci;
- Consulenza strategica per la tutela dei diritti dei creditori e dei debitori nella fase concorsuale.
Lo Studio offre un approccio integrato, tecnico e giuridico, in grado di guidare imprese, amministratori e creditori nella complessità delle procedure concorsuali, garantendo tutela legale e supporto operativo efficace.
*****************
Per ulteriori approfondimenti su questo tema o sulle relative implicazioni pratiche potete contattare:
STUDIO LEGALE BONANNI SARACENO
Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno
Piazza Giuseppe Mazzini, 27 – 00195 – Roma
Tel. +39 0673000227
Cell. +39 3469637341
@: avv.bonanni.saraceno@gmail.com



