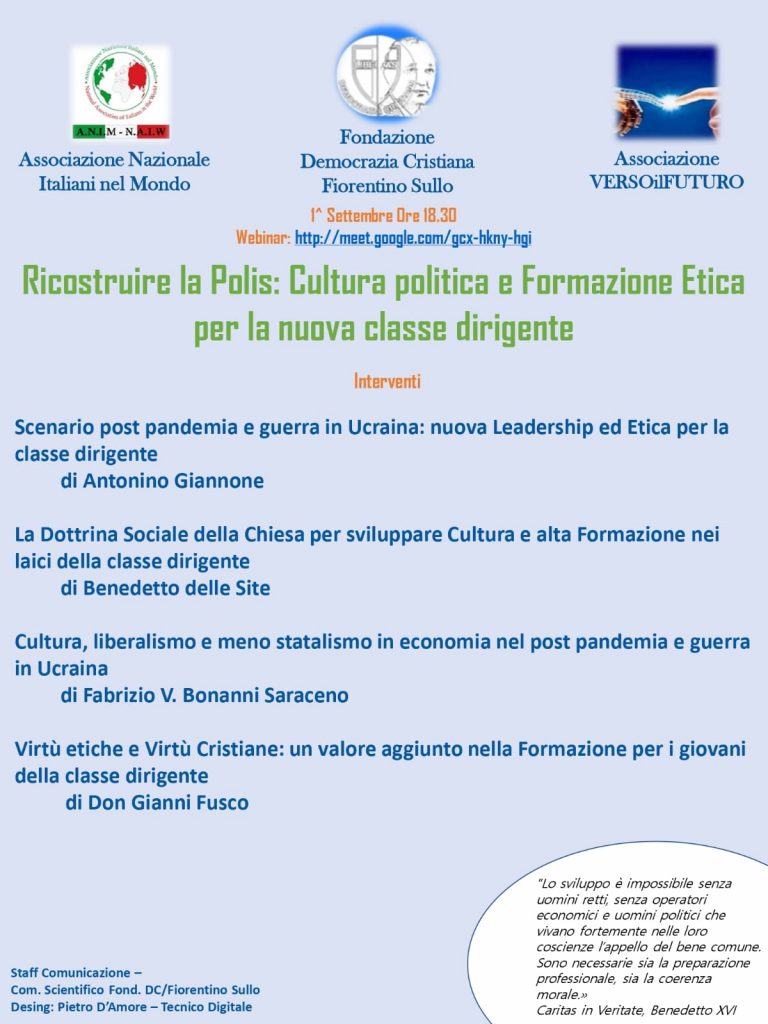Promulgata da Re Giovanni Senza Terra a Runnymede, 15 giugno 1215;
Abolita da Papa Innocenzo III;
Riconfermata da Re Enrico III Plantageneto nel 1216 e di nuovo nel 1225.
Preambolo
Giovanni, per grazia di Dio Re d’Inghilterra, signore d’Irlanda, duca di Normandia ed Aquitania e Conte d’Angiò, saluta gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti, i baroni, i giudici, le guardie forestali, gli sceriffi, gli intendenti, i servi e tutti i suoi balivi e leali sudditi.Sappiate che Noi, al cospetto di Dio, per la salvezza della Nostra anima e di quella dei nostri predecessori e dei nostri successori, a maggior gloria di Dio, ad esaltazione della Santa Chiesa, e per un migliore governo del Nostro Regno, secondo il consiglio del Nostro reverendo padre Stefano, arcivescovo di Canterbury, primate di tutta l’Inghilterra e cardinale di Santa Romana Chiesa; di Enrico arcivescovo di Dublino; di Guglielmo vescovo di Londra; di Pietro vescovo di Winchester; di Jocelin vescovo di Bath e Glastonbury; di Ugo vescovo di Lincoln; di Walter vescovo di Worcester; di Guglielmo vescovo di Coventry; di Benedetto vescovo di Rochester; di Mastro Pandolfo, subdiacono e famiglio del Papa; di Fratello Aymeric, Maestro del Cavalierato del Tempio in Inghilterra; di Guglielmo conte di Pembroke; di Guglielmo conte di Salisbury; di Guglielmo conte di Warren; di Guglielmo conte di Arundel; di Alan di Galloway conestabile di Scozia; di Warin figlio di Geraldo; di Pietro figlio di Erberto; di Uberto di Burgh, siniscalco di Poitou; di Ugo di Neville, Matteo figlio di Erberto, Tommaso Basset, Alan Basset, Filippo Daubeny, Roberto di Roppeley, Giovanni Marshal, Giovanni figlio di Ugo e di altri leali sudditi, abbiamo dato ed accordato, di Nostra propria e buona volontà, agli arcivescovi, vescovi, abati, conti, baroni, ufficiali, forestali, sceriffi, balivi, servi e a tutti i nostri fedeli e leali sudditi del Nostro Regno, le libertà qui sotto specificate, per essere da essi possedute nel Nostro Regno d’Inghilterra, inperpetuità.
01.In primo luogo, a avendo Dio come testimone, con la presente carta confermiamo a nome Nostro e dei nostri eredi che la Chiesa d’Inghilterra sarà per sempre libera, e i suoi diritti non saranno ridotti e le sue libertà non saranno violate.Che la Nostra volontà sia che questo comando venga rispettato, appare dal fatto che di Nostra libera volontà, prima che nascesse la presente disputa fra Noi e i nostri baroni, Noi abbia garantito e confermato per iscritto la libertà delle elezioni ecclesiastiche – un diritto che riconosciamo essere della più grande importanza e necessità – e questo è stato confermato da Papa Innocenzo III. Questa libertà rispetteremo Noi stessi, e desideriamo che sia rispettata in buona fede dai nostri eredi in perpetuità.A tutti gli uomini liberi del Nostro Regno abbiamo inoltre garantito, a nome Nostro e dei nostri eredi in perpetuità, tuttele libertà scritte in questa carta, da avere e tenere per loro e per i loro successori, da parte Nostra e dei nostri successori.
02.Se un barone o un’altra persona, che detenga direttamente terre della Corona a scopo militare, dovesse morire, e alla sua morte il proprio erede fosse di maggiore età e debba pagare il relevio, l’erede avrà diritto alla sua eredità dietro pagamento del relevio secondo l’antica scala. Sarebbe a dire, l’erede o gli eredi di un barone pagheranno 100 sterline per l’intera baronia e l’erede o gli eredi di un cavaliere 100 scellini al massimo come compenso per l’intero cavalierato, ed ogni uomo a cui fosse dovuto meno pagherà meno, in accordo con l’antico costume dei feudi.
03.Ma se l’erede di questa persona fosse di minore età e sotto tutela, quando raggiungerà la maggiore età avrà diritto alla sua eredità senza dover pagare riscatto.
04.Il custode della terra di un erede che sia di minore età preleverà da essa solamente rendite ragionevoli, i diritti doganali e i servizi feudali. Farà ciò senza danni o distruzioni agli uomini o alle proprietà. Se Noi abbiamo concesso la custodia di una terra ad uno sceriffo, o a qualsiasi altra persona che a Noi risponda delle tasse, e costui provochi danni o distruzioni, gliene chiederemo conto, e la terra verrà concessa a due uomini affidabili e prudenti del medesimo feudo, e costoro risponderanno, a Noi o alla persona a cui li avremo affidati, delle rendite.Se Noi abbiamo affidato o venduto il diritto di custodia di questa terra, e il responsabile causa danni o distruzioni, il colpevole perderà la custodia, che sarà affidata a due uomini affidabili e prudenti del medesimo feudo, che parimenti risponderanno a Noi.
05.Fino a quando un custode ha la custodia di una terra, gli edifici, i parchi, i vivai, gli stagni, i mulini e ogni altra pertinenza, con i proventi derivanti dalla terra stessa; e renderà agli eredi, quando avranno raggiunto la maggiore età, l’intera proprietà fornita di aratri e carri, come la stagione agricola richiede e il prodotto della terra permette di sostenere.
06.Gli eredi non siano dati in matrimonio a persone di ceto inferiore; prima che contraggano il matrimonio, esso deve essere reso noto ai loro parenti prossimi.
07.Alla morte del marito, la vedova abbia la dote e la sua eredità subito e senza ostacoli, né pagherà nulla per la sua quota legittima o la sua dote e per qualsiasi altra eredità che essa ed il marito possedevano nel momento della morte di lui, e rimanga nella casa del marito per quaranta giorni dopo la sua morte, ed entro questo termine le dovrà essere assegnata la sua dote.
08.Nessuna vedova sia costretta a risposarsi fino a quando vorrà rimanere senza marito, a condizione che dia assicurazione che non prenderà marito senza il Nostro consenso se è Nostra vassalla, o senza l’assenso del suo signore se è vassalla di un altro.
09.Né Noi né i Nostri balivi ci impadroniremo di alcuna terra o di rendite di chiunque per debiti, finché i beni mobili del debitore saranno sufficienti a pagare il suo debito, né coloro che hanno garantito il pagamento subiscano danno, finché lo stesso non sarà in grado di pagarlo; e se il debitore non potrà pagare per mancanza di mezzi, i garanti risponderanno del debito e se questi lo vorranno, potranno soddisfarlo con le terre e il reddito del debitore fino a quando il debito non sarà stato assolto, a meno che il debitore non dimostri di aver già pagato i suoi garanti.
10.Se qualcuno ha preso a prestito una somma da Ebrei, sia grande o piccola, e muore prima di aver pagato il debito, questo non produrrà interesse fino a quando l’erede si troverà nella minore età, di chiunque egli sia vassallo; e se quel credito cade in Nostre mani, Noi non chiederemo null’altro, se non la somma specificata nel documento.
11. E se un uomo muore e deve del denaro ad Ebrei, sua moglie riceva la sua dote senza dover pagare alcunché per quel debito, e se il defunto ha lasciato dei figli in minore età, si provvederà ai loro bisogni in misura adeguata al patrimonio del defunto e il debito sarà pagato con il residuo, a parte quanto dovuto ai signori feudatari; nello stesso modo sarà fatto con persone che non siano Ebrei.
12. Nessun pagamento di scutagio o auxilium sarà imposto nel Nostro Regno se non per comune consenso, a meno che non sia per il riscatto della Nostra persona e per la nomina a cavaliere del Nostro figlio primogenito e una sola volta per il matrimonio della Nostra figlia maggiore, per tali fini sarà imposto solo un ragionevole auxilium; lo stesso vale per gli auxilii della città di Londra.
13. La città di Londra abbia tutte le sue antiche libertà e le sue libere consuetudini, sia per terre sia per acque. Inoltrevogliamo e concediamo che tutte le altre città, borghi, villaggi e porti abbiano tutte le loro libertà e libere consuetudini.
14. Per ottenere il generale consenso per l’imposizione di un auxilium, eccettuati i tre casi sopra specificati, o di uno scutagio faremo convocare con Nostre lettere gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti ed i maggiori baroni, e faremo emettere da tutti i nostri sceriffi e balivi una convocazione generale di coloro che possiedono terre direttamente per Nostra concessione, in un dato giorno, affinché si trovino, con preavviso di almeno quaranta giorni, in un determinato luogo; e in tutte le lettere di convocazione ne indicheremo la causa; quando sarà avvenuta la convocazione, nel giorno stabilito si procederà secondo la risoluzione di coloro che saranno presenti, anche se non tutti i convocati si saranno presentati.
15. Noi non concediamo che alcuno chieda un auxilium ai suoi uomini liberi, se non per riscattare la sua persona, per fare cavaliere il figlio primogenito o per maritare una sola volta la figlia maggiore e per questi motivi sarà imposto solo un auxilium ragionevole.
16. Nessuno sarà costretto a fornire una prestazione gravosa per il possesso di un feudo di cavaliere o di qualsiasi altro libero obbligo.
17. I processi comuni non seguiranno la Nostra corte, ma si terranno in un luogo fisso.
18. Le inchieste di nova disseisina, de morte antecessoris, et de ultima presentacione non si svolgeranno se non nella propria contea e a questo modo: Noi stessi o, se ci troveremo fuori del Nostro Regno, il Nostro primo giudice manderemo due giudici in ogni contea quattro volte all’anno; e questi giudici, assieme a quattro cavalieri della contea eletti dalla contea stessa, terranno nella contea, in quel giorno e in quel luogo le predette assise.
19. E se nel giorno stabilito nella contea le assise predette non possono essere tenute, si trattengano tanti dei cavalieri e liberi feudatari presenti nella contea in quel giorno, quanti siano sufficienti per l’amministrazione della giustizia, secondo il numero massimo o minimo dei compiti da svolgere.
20.Nessun uomo libero sia punito per un piccolo reato, se non con una pena adeguata al reato; e per un grave reato la pena dovrà essere proporzionata alla sua gravità senza privarlo dei mezzi di sussistenza; ugualmente i mercanti non saranno privati della loro mercanzia e allo stesso modo gli agricoltori dei loro utensili; e nessuna delle predetteammende sarà inflitta se non con il giuramento di uomini probi del vicinato.
21.Conti e baroni non siano multati, se non dai loro pari, e se non secondo la gravità del reato commesso.
22.Nessun religioso sia multato per il suo beneficio laico se non secondo i modi predetti, e non secondo la consistenza del suo beneficio ecclesiastico.
23. Né villaggio né uomo potrà essere costretto a costruire ponti sulle rive, a meno che non lo debbano fare per diritto e antica consuetudine.
24. Nessuno sceriffo, conestabile, coroner od altro ufficiale reale può tenere assemblee che spettino alla Corona.
25. Ogni contea, hundredi, wapentake e trethingi, manterrà il vecchio canone, senza aumenti, tranne i nostri manieri signorili.
26. Se muore un vassallo che possiede per conto della Corona un feudo laico, si presenteranno uno sceriffo od altro ufficiale con un decreto reale di convocazione, per il debito dovuto dal defunto nei nostri confronti, costoro potranno catalogare e sequestrare i beni mobili che si trovano nel feudo laico del defunto, nella misura dell’entità del debito, sotto il controllo di uomini probi, affinché nulla sia rimosso fino a quando non sarà stato pagato il debito verso la Corona; e il rimanente sarà dato agli esecutori testamentari per eseguire il testamento del defunto; e se nulla è dovuto alla Corona, tutti i beni mobili saranno considerati proprietà del defunto, tranne le ragionevoli parti riservate alla moglie e ai suoi figli.
27. Se un uomo libero morrà senza aver fatto testamento, i suoi beni mobili saranno distribuiti ai parenti ed amici sotto il controllo della chiesa, salvi i debiti dovuti dal defunto a chiunque.
28. Nessun conestabile o altro ufficiale della Corona potrà prendere frumento od altri beni mobili da alcuno se non pagandoli immediatamente, a meno che non abbia ottenuto una dilazione per libera volontà del venditore.
29. Nessun conestabile potrà costringere un cavaliere a pagare del denaro in cambio della guardia al castello, se quello vorrà assumersi personalmente la custodia o affidarlo a un uomo probo, qualora non possa farlo per un valido motivo; e se Noi lo arruoliamo o lo mandiamo a prestare servizio d’armi, sarà affrancato dalla custodia per tutto il periodo di durata del servizio presso di Noi.
30. Nessuno sceriffo, ufficiale reale o chiunque altro potrà prendere cavalli o carri ad alcun uomo libero, per lavori di trasporto, se non con il consenso dello stesso uomo libero.
31. Né Noi né alcun ufficiale reale prenderemo legna per il Nostro castello o per Nostra necessità, se non con il consenso del proprietario del bosco.
32. Noi non occuperemo le terre di coloro che sono dichiarati colpevoli di fellonia per un periodo più lungo di un anno e un giorno, dopo di che esse saranno restituite ai proprietari del feudo.
33. Tutte le reti di sbarramento per catturare i pesci, che si trovino nel Tamigi, nel Medway e in qualsiasi altra parte dell’Inghilterra, fuorché lungo le coste marine, saranno rimosse.
34. Il mandato detto praecipe non sarà emesso in futuro per alcuno, in rapporto ad alcuna proprietà, affinché un uomo libero non possa essere privato della proprietà prima del giudizio.
35. Che vi sia una sola misura di vino, birra e frumento in tutto il Regno; e cioè il quarterio londinese, e un’unica altezza, per panni di diversa (bianca e rossa) tintura, cioè di un braccio da un bordo all’altro; lo stesso sia per i pesi e altre misure.
36. Nulla sarà d’ora in poi pagato od accettato per un mandato di inchiesta per omicidio o ferimento; esso sarà concesso gratuitamente e non sarà negato.
37. Se un uomo possiede una terra per concessione della Corona come feodifirma, sokagio o burgagio, e possiede pure una terra per concessione di un altro signore contro il servizio di cavaliere, Noi non avremo, in virtù di tali feodifirma, sokagio o burgagio, la tutela del suo erede né della terra che appartiene al feudo dell’altra persona, a meno che il feodifirma non comporti un servizio di cavaliere. Noi non avremo la tutela dell’erede o della terra di alcuno che egli possiede per conto di un altro in base ai piccoli benefici che egli tiene per conto della Corona, per servizio di pugnali, frecce o simili.
38. Nessun balivo d’ora in poi potrà portare in giudizio un uomo sulla base della propria affermazione, senza produrre dei testimoni attendibili che ne provino la veridicità.
39. Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo, né Noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo di farlo ad altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del Regno.
40. A nessuno venderemo, negheremo, differiremo o rifiuteremo il diritto o la giustizia.
41. Tutti i mercanti siano salvi e sicuri di uscire dall’Inghilterra e di entrare in Inghilterra, soggiornare e viaggiare in Inghilterra sia per terra che per acqua per comprare o vendere, liberi da ingiusta tassa secondo le antiche e buone consuetudini; eccetto in tempo di guerra e se appartengano ad un paese Nostro nemico; e se tali mercanti si trovassero nel Nostro territorio al principio della guerra, saranno trattenuti, senza alcun danno alle loro persone ed alle loro cose, fino a quando Noi o il Nostro primo giudice non saremo informati in quale modo vengano trattati i nostri mercanti che si trovino nel paese in guerra con noi; e se i nostri lì sono salvi, altrettanto siano salvi gli altri nelle Nostre terre.
42. D’ora in poi sarà lecito a chiunque uscire ed entrare nel Nostro Regno, salvo e sicuro, per terra o per acqua, salva la fedeltà a Noi dovuta se non per un breve periodo in tempo di guerra, per il comune vantaggio del Regno; eccetto quelli che sono stati imprigionati o messi fuori legge secondo le leggi del Regno, e le persone appartenenti ad un paese in guerra con noi, e i mercanti, si farà come è stato sopra detto.
43. Se alcuno possiede una proprietà in eskaeta come gli honours di Wallingford, Nottingham, Boulogne, Lancaster, od altre proprietà eskaete che sono in Nostro possesso e che sono baronie, alla sua morte il suo erede ci dovrà solo il riscatto ed il servizio di cui sarebbe stato debitore verso il barone, se la baronia fosse stata ancora di proprietà del barone; e Noi la terremo nello stesso modo in cui la teneva il barone.
44. Gli uomini, che vivono al di fuori della foresta, d’ora in poi non dovranno in futuro venire davanti ai giudici della foresta in seguito ad una citazione comune, a meno che non siano implicati in un’azione legale o non siano garanti per qualcuno che sia stato arrestato per reati contro la foresta.
45. Noi nomineremo giudici, conestabili, sceriffi od ufficiali se non coloro che conoscano la legge del Regno e vogliano ben osservarla.
46. I baroni che hanno fondato abbazie e possono provarlo con documenti del Regno d’Inghilterra o per antico possesso, potranno amministrare le dette abbazie in vacanza dell’abate, com’è loro diritto.
47. Tutti i territori che sono stati dichiarati foreste durante il Nostro Regno, perderanno immediatamente tale stato. Lo stesso sarà per le sponde dei fiumi poste sotto riserva durante il Nostro Regno.
48. Tutte le cattive consuetudini relative alle foreste e alle riserve, alle guardie di foreste e di riserve, sceriffi e loro aiutanti, sponde dei fiumi e loro custodi, siano immediatamente controllate da un comitato di dodici cavalieri giurati della stessa contea che devono essere eletti ugualmente da un comitato di uomini probi, ed entro quaranta giorni dal compimento dell’inchiesta dovranno essere, senza possibilità di revoca, eliminate (lo stesso valga se Noi saremo fuori dell’Inghilterra, purché Noi o il Nostro primo giudice ne saremo stati prima informati).
49. Noi restituiremo immediatamente tutti gli ostaggi e le carte consegnatici dai sudditi inglesi a garanzia della pace e della fedeltà.
50. Rimuoveremo completamente dalle loro cariche i parenti di Gerard de Athée, d’ora in poi non permetteremo loro di avere più alcun ufficio in Inghilterra. Le persone in questione sono: Engelard de Cigogné, Peter e Guy, Andrew de Chanceaux, Guy de Cigogné, Geoffrey de Martigny e i suoi fratelli, Philip Marc con i suoi fratelli e suo nipote Geoffrey, e tutti i loro seguaci.
51. Non appena la pace sarà restaurata allontaneremo dal Nostro Regno tutti i cavalieri stranieri, balestrieri, sergenti, mercenari che sono arrivati con cavalli e armi con grave danno per il Regno.
52. Se qualcuno è stato da Noi spossessato o privato senza un legale processo dei suoi pari, di terre, castelli, delle libertà o dei diritti, immediatamente glieli restituiremo; e se sorgono casi controversi, essi saranno decisi dal giudizio dei venticinque baroni cui si fa riferimento sotto relativamente alla sicurezza della pace. Poi per tutte quelle cose di cui qualcuno è stato spossessato senza un processo legale dei suoi pari, da parte di Nostro padre Re Enrico o di Nostro fratello Re Riccardo, e si trovi in Nostro possesso o nelle mani di altri sotto la Nostra garanzia, Noi dovremo avere un termine comunemente concesso a chi è segnato della croce; eccetto quei casi in cui sia iniziato un processo o aperta un’inchiesta per Nostro ordine, prima della sospensione per la Nostra croce; al Nostro ritorno dal pellegrinaggio o in caso di rinuncia al pellegrinaggio, immediatamente sarà resa piena giustizia.
53. Avremo ugualmente una proroga e lo stesso sarà nel rendere giustizia per l’eliminazione del vincolo sulle foreste o per la sua conservazione, qualora queste siano state afforestate da Nostro padre Enrico o da Nostro fratello Riccardo, e per la custodia delle terre che si trovano nel feudo di un altro, la cui custodia abbiamo avuto fino ad ora a causa di un feudo tenuto per Nostro conto da un terzo, in virtù del servizio di cavaliere; lo stesso sarà infine per le abbazie fondate nel feudo di altra persona da noi, qualora questa avanzi delle pretese su di esse; e al Nostro ritorno, o nel caso di rinuncia al pellegrinaggio, Noi concederemo piena giustizia a tutte le lagnanze riguardanti queste cose.
54. Nessuno sarà arrestato od imprigionato per la morte di una persona su accusa di una donna, a meno che la persona morta non sia il marito della donna.
55. Tutte le somme che ci sono state versate ingiustamente ed in contrasto con la legge del paese, e tutte le ammende da Noi esatte indebitamente, saranno interamente restituite; ovvero saranno sottoposte al giudizio dei venticinque baroni cui si fa riferimento più sotto, nella clausola della sicurezza per la pace, o della maggioranza degli stessi, unitamente al predetto Stefano, arcivescovo di Canterbury, se sarà presente e di quanti altri egli vorrà condurre con sè. E se non potrà essere presente, la riunione proseguirà senza di lui; se però uno dei venticinque baroni sarà implicato anche lui in una causa simile, il suo giudizio sarà escluso ed un altro sarà scelto come sostituto dai rimanenti ventiquattro eletti, dopo aver giurato.
56. Se un Gallese sarà stato da Noi privato delle terre, della libertà o qualsiasi altra cosa, in Inghilterra o nel Galles, senza il legale giudizio dei suoi pari, dovrà immediatamente riavere in restituzione quanto perduto; e se la questione dovesse essere controversa, sarà decisa nella Marchia dal giudizio dei suoi pari: per i possedimenti in Inghilterra, secondo la legge dell’Inghilterra; per i possedimenti che si trovano nel Galles con la legge del Galles; per i possedimenti della Marchia, secondo la legge della Marchia. Lo stesso facciano i Gallesi con Noi e i nostri sudditi.57. Nel caso in cui un Gallese sia stato privato di qualcosa senza il giudizio legale dei suoi pari, da parte di Nostro padre Re Enrico o Nostro fratello Re Riccardo, e si trovi in Nostro possesso o nelle mani di persone sotto la Nostra garanzia, Noi dovremo avere una proroga della durata usualmente concessa ai segnati della croce a meno che un processo non abbia avuto inizio od una inchiesta non sia stata aperta per Nostro ordine, prima che Noi prendessimo la croce; al Nostro ritorno, ovvero all’atto della rinuncia al Nostro pellegrinaggio, renderemo immediatamente piena giustizia secondo le leggi del Galles e delle regioni suddette.58. Restituiremo immediatamente il figlio di Llewelyn, gli ostaggi gallesi e tutte i documenti che ci sono stati dati come pegni per la pace.
59. Noi faremo ad Alessandro, re di Scozia, per quel che riguarda la restituzione delle sorelle e degli ostaggi e le sue libertà ed i suoi diritti, nello stesso modo che verso gli altri nostri baroni d’Inghilterra, a meno che, dai documenti che ricevemmo da suo padre Guglielmo, già Re di Scozia, non risulti che egli debba essere trattato diversamente; e ciò sarà stabilito dal giudizio dei suoi pari nella Nostra corte.
60. Tutte le consuetudini e le libertà suddette che abbiamo concesse nel Nostro Regno, e per quanto ci compete, siano osservate da tutti gli uomini del Nostro Regno, siano ecclesiastici o laici; le osservino, per quanto ad essi compete, nei confronti di coloro ad essi soggetti.
61. Poiché Noi abbiamo fatto tutte queste concessioni per Dio, per un miglior ordinamento del Nostro Regno e per sanare la discordia sorta tra Noi ed i nostri baroni, e poiché Noi desideriamo che esse siano integralmente e fermamente in perpetuo godute, diamo e concediamo le seguenti garanzie.I baroni eleggano venticinque baroni del Regno che desiderano, allo scopo di osservare mantenere e far osservare con tutte le loro forze, la pace e le libertà che ad essi abbaiamo concesso e che confermiamo con questa Nostra carta.Se noi, il Nostro primo giudice, i nostri ufficiali o qualunque altro dei nostri funzionari offenderemo in qualsiasi modo un uomo o trasgrediremo alcuno dei presenti articoli della pace e della sicurezza, e il reato viene portato a conoscenza di quattro dei venticinque baroni suddetti, costoro si presenteranno di fronte a Noi o se saremo fuori dal Regno, al nostro.E se Noi o, in Nostra assenza, il Nostro primo giudice non faremo tale riparazione entro quaranta giorni dal giorno in cui il misfatto sia stato dichiarato a Noi od a lui, i quattro baroni metteranno al corrente della questione il rimanente dei venticinque che potranno fare sequestri ai nostri danni ed attaccarci in qualsiasi altro modo e secondo il loro arbitrio, insieme alla popolazione del Regno, impadronendosi dei nostri castelli, delle Nostre terre, dei nostri beni o di qualsiasi altra cosa, eccettuate la Nostra persona, quella della regina e dei nostri figli; e quando avranno ottenuto la riparazione, ci obbediranno come prima. E chiunque nel Regno lo voglia può di sua spontanea volontà giurare di obbedire agli ordini dei predetti venticinque baroni per il conseguimento dei suddetti scopi, e di unirsi a loro contro di noi, e Noi diamo pubblicamente e liberamente autorizzazione di dare questo giuramento a chiunque lo voglia e non proibiremo a nessuno di pronunciarlo.Tutti coloro del paese che per se stessi e di loro spontanea volontà non vogliano prestare giuramento ai venticinque baroni per danneggiarci o molestarci insieme a loro, li costringeremo a giurare per Nostro ordine, come sopra è stato detto.E se qualcuno dei venticinque baroni morisse od abbandonasse il paese o fosse impedito in qualunque altro modo dall’adempiere le proprie funzioni, gli altri dovranno eleggere dai predetti venticinque un altro al suo posto, a loro discrezione, e questi dovrà a sua volta prestare giuramento allo stesso modo degli altri.In tutti gli adempimenti di questi venticinque baroni, se dovesse accadere che i venticinque siano presenti e tra di loro siano in disaccordo su qualcosa o uno di loro che è stato convocato non vuole o non può venire, ciò che la maggioranza dei presenti avrà deciso o ordinato, sarà come se avessero acconsentito tutti i venticinque; e i suddetti venticinque giurino di osservare fedelmente tutte le cose suddette e di fare tutto ciò che è loro possibile per farle osservare.E Noi non chiederemo nulla, per Noi o per altri, perché alcuna parte di queste concessioni o libertà sia revocata o ridotta; e se qualcosa sarà richiesta, sarà considerata nulla e invalida e Noi non potremo usarla per Noi o tramite altri.
62. E ogni malanimo, indignazione e rancore sorti tra Noi ed i nostri sudditi, religiosi e laici, dall’inizio della discordia abbiamo a tutti pienamente rimesso e perdonato. Inoltre, tutte le trasgressioni arrecate in occasione della dettadiscordia, tra la Pasqua del sedicesimo anno del Nostro Regno, alla restaurazione della pace, a religiosi e laici, per quanto ci compete, abbiamo pienamente condonato. Inoltre abbiamo fatto fare per essi delle lettere patenti per testimonianza, del signore Stefano, arcivescovo di Canterbury, del signore Enrico, arcivescovo di Dublino, dei predetti vescovi e maestro Pandolfo, per la sicurezza di questa e delle concessioni predette.
63. Per queste ragioni desideriamo e fermamente ordiniamo che la Chiesa d’Inghilterra sia libera e che i nostri sudditi abbiano e conservino tutte le predette libertà, diritti e concessioni, bene e pacificamente, liberamente e quietamente, pienamente e integralmente per se stessi e per i loro eredi, da Noi e dai nostri eredi, in ogni cosa e luogo, in perpetuo, come è stato detto sopra.Abbiamo giurato, sia da parte Nostra sia da parte dei baroni, che tutto ciò che abbiamo detto sopra in buona fede e senza cattive intenzioni sarà osservato in buona fede e senza inganno. Ne sono testimoni le summenzionate persone e molti altri.Dato per Nostra mano nel prato chiamato Runnymede, tra Windsor e Staines, il quindicesimo giorno di Giugno, diciassettesimo anno del Nostro Regno